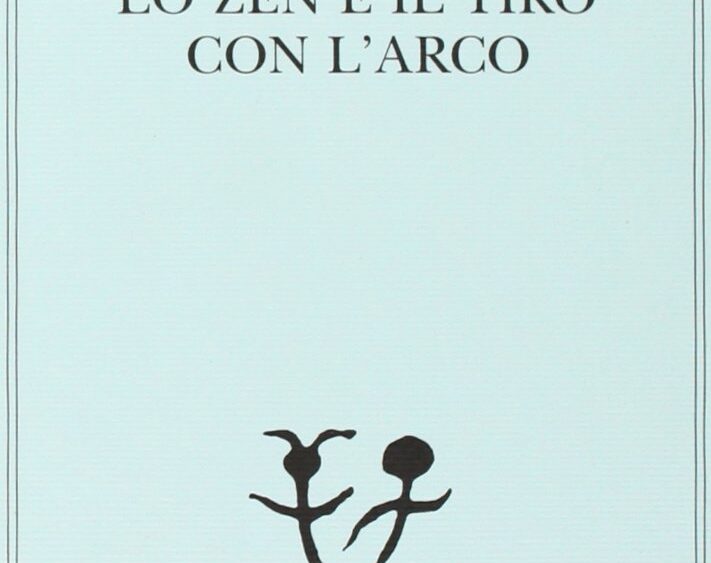Il riferimento a libro: Lo Zen e il tiro con l’arco è chiaro. Lo voglio consigliare ai colleghi, ma stavolta sopratutto ai pazienti che in definitiva sono i protagonisti della loro rinascita. Forse lo trovo più adatto ai pazienti che già seguono la neurocognitiva di Perfetti, perchè ogni giorno si trovano a vivere una relazione con il proprio terapista che sono certo li farà immedesimare nelle pagine di questo libro. Quante volte il paziente si è sentito frustrato quando il terapista gli ha chiesto di rilassare la mano e il paziente che ha imparato a controllare la spasticità con molta attenzione ci riesce, ma alla prima distrazione si ritrova con la mano rigida come un pezzo di legno.
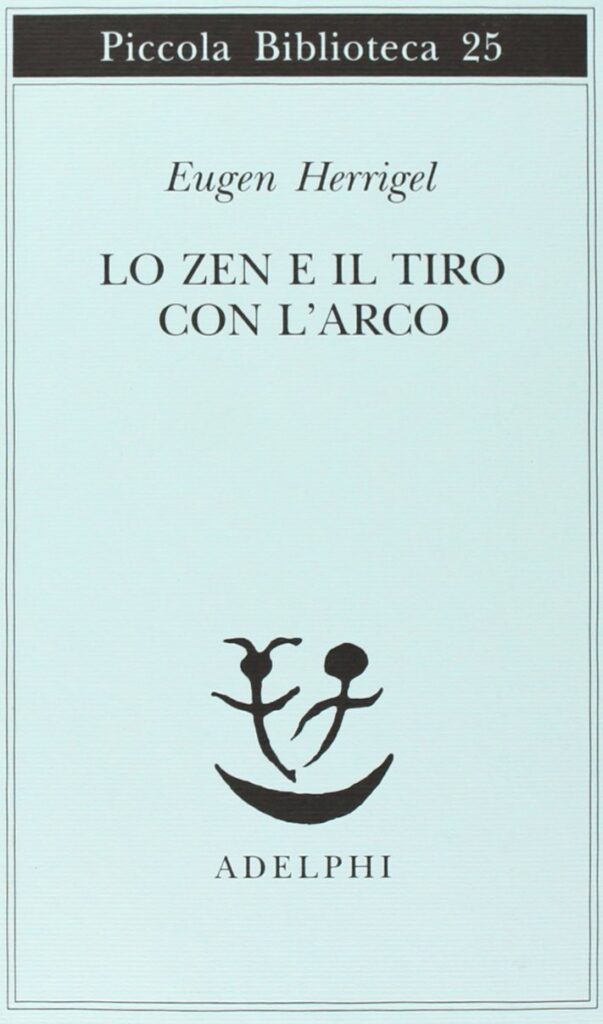
https://youtu.be/z_Dp7CoUOyM
I più disciplinati riescono a mantenere questa attenzione per tanto tempo durante il giorno, si muovono con cautela tipo artificieri e magari riescono anche ad automatizzare parte di questo controllo, ma sia il paziente che il terapista si interrogano su questa pratica perchè rischia di allontanarLI dalla spontaneità con la quale è fatto l’agire umano.
Eugen Herrigel è un professore tedesco di filosofia che si trasferisce in Giappone per lavoro e vuole essere introdotto allo Zen per questo sceglie una delle arti in cui lo zen si applica da secoli: appunto il tiro con l’arco. Qui si racconta il suo processo di apprendimento, il conflitto tra il raziocinio occidentale da una parte e la solennità della cerimonia spirituale dall’altra. Eugen era alla ricerca della tecnica, ma si trovava di fronte a un mondo completamente nuovo fatto di spiritualità e misticismo.
Immagino lo sguardo di chi abita il mondo della scienza, quella fatta di verità che si possono misurare, di fronte a parole eretiche come mistico e spirituale e forse anche pericolose se associate al mondo della medicina, in un ambiente dove il paziente, in maniera del tutto comprensibile, è alla ricerca di una soluzione immediata: un integratore miracoloso, un guanto robotico, un intervento chirurgico risolutivo. Tuttavia dalla dottrina Zen possiamo ricavare alcune riflessioni sul concetto di intenzionalità. Sia che si tratti di rilassare la mano, sia che si tratti di afferrare un oggetto, siamo sempre molto rivolti all’obiettivo, al risultato esterno, un po’ come accadeva al protagonista le prime volte che si è trovato a scoccare la freccia con il suo arco e le parole del maestro lo portavano in confusione:
“Tutto è vuoto, anzi non c’è nemmeno la parola del vuoto, da tale vuoto assoluto sboccia meravigliosamente l’azione…la vera arte è scopo senza intenzione”. Sembrano un rompicapo le parole del maestro Zen e lo erano anche per Eugen che sentiva di trovarsi di fronte a un paradosso: intenzionalmente doveva spogliarsi di qualsiasi intenzione.
In riabilitazione il terapista è molto attento al tipo di intenzionalità del proprio paziente, infatti lo osserva e ascolta le sue parole con molta attenzione. Ad esempio quando gli si chiede di rilassare la mano sul tavolo e il paziente cerca di produrre il movimento di apertura ci rendiamo conto di un problema di intenzionalità: il paziente non sta rilassando, non sta adattando la superficie della propria mano alla superficie del tavolo, la sta aprendo e lo sta facendo con forza e infatti il risultato spesso è proprio l’opposto, si irrigidisce.
Allo stesso modo quando il paziente con l’aiuto dell’altra mano cerca di vincere la tensione aprendosela e premendola sul piano, qui l’intenzionalità vede come protagonista la mano “buona” che deve assoggettare la mano plegica come se fosse un oggetto esterno. “Questa scema non vuole aprirsi” sono parole che svelano alcune relazioni intenzionali come quella che vede la mano come un qualcosa, anzi un qualcuno di esterno che non obbedisce ai comandi di una mente che si trova al di sopra del corpo e quando un superiore da un ordine a un sottoposto che non obbedisce o grida l’ordine con più veemenza e quindi mettendo più forza o alla fine lo punisce con l’isolamento.
Ce ne sono tanti di esempi, c’è anche il paziente che riesce a rilassare la mano, ma ti accorgi che per farlo si deve distrarre, guarda fuori dalla finestra o da uno sguardo alla televisione e si ritrova la mano rilassata; anche questo rivela un’intenzionalità, il paziente si estranea perché se pensa al compito rischia di ricadere nel tentativo di aprire o di FARE qualcosa, c’è anche il paziente che respira profondamente e rilassa tutto il corpo con la speranza che questo rilassamento generalizzato investa anche la mano e in genere lo fa anche se non a sufficienza, c’è chi se la carezza: un’intenzionalità che denota premura, ma anche una certa separazione con la propria mano.
A questo punto il terapista con l’esercizio vuole guidare il paziente a creare nuove relazioni intenzionali con il proprio corpo, con l’ambiente e con l’azione, allora ad esempio con un esercizio di riconoscimento di moquette lo aiuta a imparare che per adattare la mano alla superficie è importante sentire, ma non solo sentire se è dura, morbida, liscia o ruvida quindi accedendo a un livello sensoriale, ma provare qualcosa in più da questa relazione ad esempio se gradevole, confortevole o scomoda quindi a un livello cognitivo; più ricco. Qui il terapista per aiutare il paziente a creare relazioni intenzionali più profonde e che risuonino con il suo vissuto, con i suoi ricordi anche precedenti all’ictus, aiuta il paziente ad associare l’esercizio a uno di questi ricordi, ovviamente ricordi che siano ricchi di significato e di emozioni, allora il paziente potrebbe ricordare di quando accarezzava la testa del suo amato cane che oggi non c’è più, e che gli regalava tanta pace, quindi la superficie non è più solo morbida e nemmeno solo gradevole, ma permette di vivere un’esperienza ancora più profonda fatta di emozioni, in questo caso di pace, e il terapista inizia ad aiutare il paziente a creare dei collegamenti tra questo ricordo, l’esercizio e l’azione da recuperare, quella di adattare la mano alla superficie del tavolo, gli chiede anche di ricordare la reazione del cane quando lo accarezzava; la carezza è tale quando è piacevole a chi la fa e a chi la riceve, quindi è necessario creare una certa intenzione affinché questa sintonia reciproca si realizzi. A questo punto il paziente dopo questo viaggio cosciente tra diversi mondi, può tornare all’azione iniziale con un nuovo bagaglio di relazioni intenzionali, sicuramente più adatte, più ricche e più affini al proprio vissuto.
Il nostro Eugen alle prese con il tiro con l’arco non ha una lesione cerebrale e quindi non soffre di spasticità, di tutte quelle alterazioni della percezione, dell’attenzione e degli altri processi cognitivi che richiedono esercizi specifici per il recupero e per innescare la plasticità cerebrale, ma era anche lui alla continua ricerca delle giusta intenzionalità per tendere l’arco e scoccare la freccia e si scontrava con la richiesta assurda del maestro di non pensare e di non riflettere sull’azione.
“Il tiro giusto nel momento giusto, non avviene perché lei non si stacca da se stesso, lei non è teso verso il compimento, ma attende il fallimento… La vera arte è scopo senza intenzione”
Il maestro insegna al suo allievo a isolarsi dal mondo e da se stesso attraverso la respirazione e dirigendo tutta l’attenzione su di essa fino a che senza nessun ulteriore atto intenzionale questa inizia a rallentare e a sottrarsi dal controllo cosciente fino a che: non stiamo più respirando, ma SI è respirati. Questo SI ricorre spesso nel libro: “Non aprire la mano con intenzione, lasciamo che le cose afferrino noi e non che noi afferriamo le cose” “Non siamo noi a tirare la freccia, è la freccia che SI tira”.
Eugen intuiva, ma non capiva per questo chiese al maestro: “Chi o casa è questo SI”
il maestro rispose: “Quando lo avrà capito, non avrà più bisogno di me”