Che cos’è Riabilitazione Neurocognitiva?
È l’approccio di riabilitazione nato in Italia alla fine degli anni ’60 dagli studi del medico italiano Carlo Perfetti per questo più diffusamente conosciuto come Metodo Perfetti ed Esercizio Terapeutico Conoscitivo (E.T.C). Secondo la teoria neurocognitiva della riabilitazione: “la qualità del recupero, sia di tipo spontaneo sia guidato dal riabilitatore, dipende in maniera strettissima dal tipo dei processi cognitivi attivati e dalla loro modalità di attivazione”
Come nasce il Metodo Perfetti?
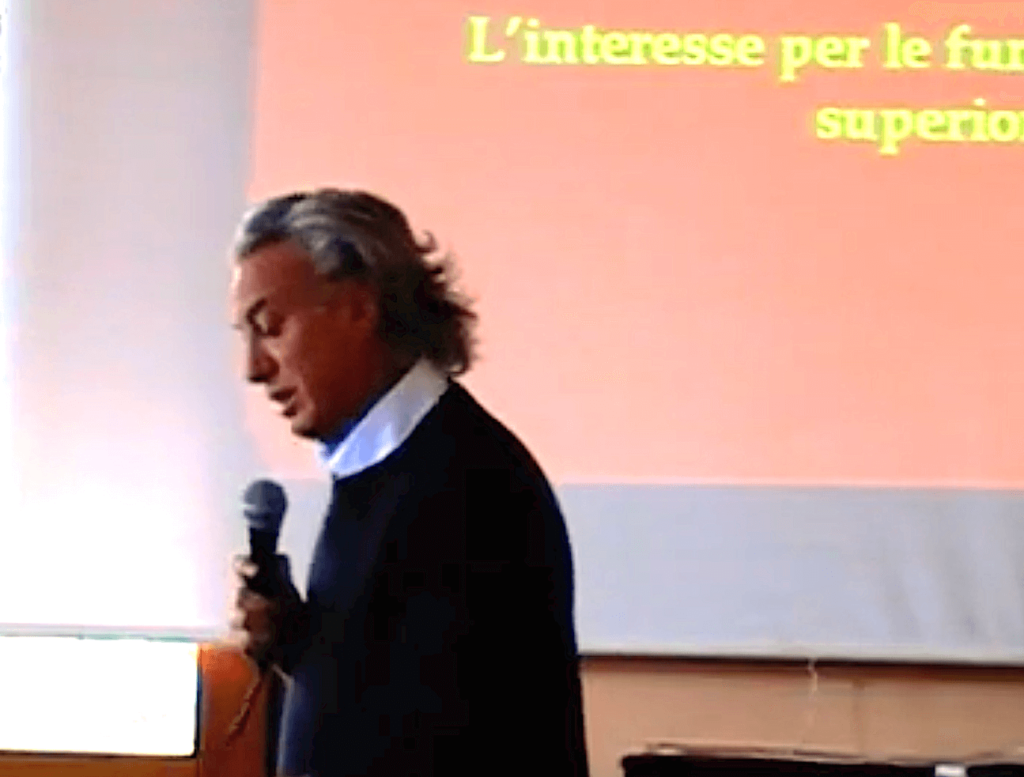
Carlo Perfetti si specializza in Clinica delle Malattie mentali e Nervose, alla fine degli anni sessanta inizia a interessarsi di riabilitazione e nello specifico della riabilitazione del paziente con ictus cerebrale, paralisi cerebrale infantile e con spasticità. Studia con interesse la fisioterapia neuromotoria in voga in quel periodo come il metodo Vojya, Kabat e infine Bobath, quest’ultima ritenuta dal medico toscano la più interessante nel panorama, ma iniziava nel frattempo ad appassionarsi ad un problema finora insulto e ritenuto insuperabile, quello del recupero della mano del paziente emiplegico.
Dall’elaborazione di questo problema e dalle influenze storiche, sociali, culturali e scientifiche di quel periodo inizia a dare vita a una teoria della riabilitazione che considerasse anche i processi cognitivi dei pazienti e non solo le sue abilità di contrarre fibre muscolari e di attivare schemi di riflessi. Se l’ictus colpisce il cervello del malato, allora le funzioni cerebrali devono essere considerate nell’esercizio; questo presupposto riassume a grandi linee le scelte terapeutiche identitarie dei trattamenti cognitivi.
Come funziona il Metodo Perfetti?
Per entrare nel vivo della metodo neurocognitivo riteniamo utile mostrare un esempio di esercizio affinchè fin da subito si evidenzino le caratteristiche e le differenze con le attività che siamo abituati a vedere nei confronti dei pazienti con patologia neurologica e nello specifico nelle conseguenze da ictus (anche se vedremo in seguito che si tratta di un metodo di lavoro applicabile a tutte le affezioni che richiedano attività di fisioterapia e non solo per chi ha subito un ictus cerebrale).
Prima della visione del video sono necessari alcuni chiarimenti: l’esercizio è una esperienza personalizzata che il riabilitatore costruisce in base alle esigenze del singolo paziente, il video che mostreremo non è altro che parte di una strategia per iniziare a orientarci sui principi della neurocognitiva, per dare una prima valutazione e invitiamo a provarlo in casa anche in famiglia per avere un’idea più chiara, ma tenendo in mente che ogni attività va realizzata “su misura”; sulla persona… CON la persona.
Discutiamo sulle caratteristiche e le differenze…
Spesso mi sono trovato a visitare le cliniche dove ero stato invitato per svolgere dei corsi di formazione, i direttori compiaciuti mi mostravano le loro palestre all’avanguardia, con la migliore attrezzatura, sistemi tecnico informatici, ma quasi tutte in comune avevano una serie di lettini uno di fronte all’altro dove erano sdraiati i pazienti e dove su di loro i terapisti eseguivano le varie manovre e mobilizzazioni. Spazi a volte conviviali dove i terapisti parlavano tra di loro o con i pazienti, di temi personali o di attualità, qui l’ambiente e le pratiche manuali dei terapisti mettevano i pazienti in una posizione passiva senza che venisse coinvolta l’attenzione nei confronti del corpo, aspetto che invece nel video appena mostrato rappresenta uno degli aspetti particolari dell’esercizio neurocognitivo, il paziente non avrebbe avuto la possibilità di riconoscere il cerchio senza un ricorso all’attenzione.
Perchè dopo un ictus l’esercizio terapeutico non può fare a meno del ricorso a l’attenzione?
Ricordiamo sempre che un ictus ha colpito il cervello e non i muscoli e nonostante il paziente abbia mantenuto la sua intelligenza e sia rimasto la stessa persona brillante e non abbia perduto le sue competenze tanto da poter ritornare al suo lavoro, questo non significa che non abbia subito delle alterazioni nell’attenzione nei confronti del corpo. Molti lettori che sono pazienti o familiari si ricorderanno nelle prime settimane o mesi in cui (specialmente nei pazienti con emiparesi a sinistra) era presente una certa difficoltà a guardare e a prestare attenzione verso il lato della lesione. Questa sindrome si chiama neglect e non è un problema della vista, bensì dell’attenzione nei confronti delle informazioni provenienti dal lato del corpo coinvolto nella paresi e anche se nei mesi a seguire, anche con l’aiuto dei familiari, il paziente abbia imparato a sforzarsi a guardare verso il lato paralizzato, spesso rimangono alcuni difetti dell’attenzione nei confronti del corpo e questi rappresentano un ostacolo al recupero dell’abilità motoria. Anche il paziente con emiplegia destra soffre di disturbi dell’attenzione nei confronti del corpo e del movimento, tra i lettori ci sarà chi avrà ascoltato dal professionista il termine aprassia, anche in questo quadro clinico il paziente presenta difficoltà nel dirigere l’attenzione nei confronti del corpo. Al paziente a cui non sia mai stato associato un disturbo dell’attenzione come nei casi citati di neglect o aprassia, dovrà considerare un altro aspetto fondamentale e cioè che se il danno è avvenuto nel cervello ed è il cervello a necessitare di essere riattivato per permettergli di creare nuove connessioni, farsi muovere una parte del corpo o muoverla ma senza dirigere l’attenzione in modo specifico è possibile che non porti agli obiettivi e ai risultati sperati.

Tra le altre differenze troviamo quella di chiudere gli occhi e questo nelle prime fasi del trattamento serve ad aiutare il paziente a privilegiare le sensazioni provenienti dal corpo piuttosto che dalla vista. Nell’esercizio neurocognitivo del video assume un significato importante anche la memoria. Sono consapevole che quando menziono la memoria come elemento cognitivo importante per il miglioramento, il paziente sente di non averla perduta, anzi in molte occasioni riferisce di avere una memoria ancora più allenata e di ricordarsi molte più cose in seguito all’ictus e qui sono costretto a chiarire che la memoria che ha subito menomazioni non è quella legata alla storia del paziente, o alle password del computer, mi riferisco alla memoria che è in stretta relazione con le sensazioni del corpo, la memoria del corpo in azione; è questa che in seguito ad un ictus potrebbe aver subito un’alterazione e che necessita di essere riattivata.
Il ricorso alla percezione risulta chiaro nel video e il motivo per cui è importante che in fisioterapia si consideri la percezione è che il movimento non può essere studiato escludendo ciò che siamo in grado di percepire grazie alla nostra interazione con gli oggetti e con l’ambiente, perchè sono proprio queste informazioni a guidare il movimento che a sua volta ha lo scopo di raccogliere informazioni sempre più precise. Anche in questo caso il paziente riferisce di non aver subito deficit della percezione perchè memore delle visite del neurologo quando si trovava in ospedale che in sede di valutazione, pigiando con la punta della penna sulla pelle o a volte toccando con un dito una parte del corpo, chiedeva al paziente se fosse in grado di percepire, tuttavia, la percezione di cui abbiamo bisogno per realizzare il movimento va ben oltre il semplice sentire la presenza o meno del contatto sulla pelle, ma richiede anche l’abilità di riconoscere l’esatta posizione nello spazio di tutti i nostri segmenti del corpo; abilità che prende il nome di cinestesia.
Il terapista stranamente non ha chiesto al paziente di partecipare al movimento sollevando o aprendo il braccio volontariamente, ma gli ha chiesto di lasciarsi condurre, ci troviamo pertanto di fronte all’assenza della richiesta di contrazioni muscolari visibili. Mi sento di aggiungere l’aggettivo “visibili”, perchè in un esercizio in cui il paziente è chiamato a dover lasciarsi guidare e quindi adattare il tono dei muscoli, che come sappiamo in seguito ad un ictus appaiono ipertonici e spastici, non significa che il paziente non stia partecipando al movimento o che l’esercizio sia passivo, infatti il paziente con ictus per lasciarsi condurre deve controllare il tono dei muscoli e imparare a ridurre la tensione che rappresenta un ostacolo evidente alla guarigione in termini di qualità. Riconosco che nell’immagine del paziente, per recuperare sia convinto di dover fare sforzi e impegnarsi a muovere, purtroppo la realtà delle conseguenze delle lesioni cerebrali è diversa e per imparare a muoversi lo sforzo potrebbe risultare anche controproducente aumentando la spasticità che invece il paziente vuole risolvere.

Anche nei confronti del linguaggio del terapista notiamo delle differenze rispetto a una fisioterapia tradizionale, infatti qui il professionista non utilizza il linguaggio per impartire ordini, che il paziente deve soddisfare con una risposta motoria, piuttosto si tratta di un linguaggio utile alla risoluzione di un problema, quest’ultimo altro grande protagonista dell’esercizio di neurocognitiva di Perfetti, in quanto in grado di attivare tutti i processi cognitivi necessari alla sua risoluzione. La stimolazione dei processi cognitivi per frammentare il corpo incide sullo sviluppo di apprendimento e abilità motorie. Non un esercizio puramente mentale come potrebbe avvenire durante una valutazione neuropsicologica, ma un vero e proprio esercizio di riabilitazione motoria e cognitiva allo stesso tempo.
Per chi è adatto il Metodo Perfetti?
in questi vent’anni di attività come riabilitatore neurocognitivo ho avuto la possibilità di ascoltare molti pazienti a cui spesso erano state passate delle informazioni non corrette sul metodo: alcuni sostenevano che il metodo non fosse adatto al paziente privo di deficit cognitivi, altri al contrario non lo ritenevano adatto per chi invece aveva problemi cognitivi. Come abbiamo discusso nei paragrafi precedenti, avere disturbi cognitivi non significa avere necessariamente una demenza o aver perduto il senno. Dobbiamo considerare le funzioni cognitive come le funzioni del cervello, esattamente come attribuiamo ai polmoni le funzioni respiratorie e al cuore quelle circolatorie, è chiaro che una lesione ai polmoni o al cuore che non risultino fatali, avranno delle ripercussioni più o meno evidenti a seconda della gravità, allo stesso modo accade nel cervello che subisce un ictus e quindi una lesione in seguito ad una ischemia o di un’emorragia.
Da addetto ai lavori quando mi riferisco a un paziente con disturbi cognitivi, faccio riferimento a tutti i pazienti colpiti da ictus che potrebbe avere alcuni difetti della sensibilità, alcune difficoltà nel considerare delle parti del corpo, a ricordare alcuni aspetti del movimento, a costruire una previsione dell’azione completa, o nell’apprendimento di nuovi movimenti, tutti elementi che conducono all’assenza o alterazione del movimento, ma che non coincidono con l’intelligenza del paziente e che ripeto con vigore, sono certo non abbia subito alterazioni e che permetta anche un reintegro totale al lavoro e nell’ambiente sociale. Per quanto riguarda invece la non adattabilità del metodo ai soggetti con disturbi cognitivi, purtroppo si tratta di un’affermazione prodotta da chi non è a conoscenza dell’approccio neurocognitivo e probabilmente in termini più generali della riabilitazione in sé perchè, professionalmente e deontologicamente è chiaro che un paziente che presenta disturbi cognitivi abbia bisogno di una terapia che lo aiuti ad attivarli e riorganizzarli. Il metodo è adatto pertanto a tutti i pazienti che avendo subito un ictus abbiano necessità di recuperare e migliorare il movimento.
Per quali patologie è adatto il Perfetti?
Anche in questo caso è necessario un chiarimento, mi riferisco spesso ai pazienti con emiplegia, quelli che per intenderci hanno subito un ictus, e anche i nostri programmi di riabilitazione di Stroke Therapy Revolution sono esclusivi per chi ha esiti di ictus e non altre malattie, ma questo non significa che il metodo non sia applicabile ad altre patologie neurologiche, ortopediche o reumatologiche. Il Prof Carlo Perfetti ha iniziato i suoi studi con le lesioni cerebrali e la maggior parte delle sue ricerche coinvolgevano l’ictus, questa era una sua passione specifica che ha trasferito a noi allievi, ma anche tra gli allievi di Perfetti ci sono quelli che si sono specializzati nelle patologie dell’età evolutiva, nei parkinsonismi, nella sclerosi multipla e nelle sindromi ortopediche, nei casi di dolore neuropatico causato dall’ictus stesso o al dolore da arto fantasma nel caso di amputazione. Anche ai nostri di allievi che seguono i corsi nella nostra Accademia Neurocognitiva offriamo un piano formativo specialmente improntato sulla riabilitazione dell’ictus cerebrale, ma i professionisti iscritti sono tutti consapevoli che ognuno di loro applicherà la teoria neurocognitiva nell’ambito dell’area di loro interesse.
Che differenza c’è tra Metodo Perfetti, Riabilitazione Neurocognitiva ed Esercizio Terapeutico conoscitivo?
In sostanza non c’è nessuna differenza sono solo i nomi con i cui è conosciuto l’approccio ideato da Carlo Perfetti. Il motivo del cambiamento dei nomi è che in effetti i nomi definiscono le cose e se le cose nel tempo cambiano anche i nomi dovrebbero adattarsi e questo è stato il motivo per cui nel tempo si è passati dal primo nome che è stato “Controllo Sequenziale Progressivo” a “Esercizio Terapeutico Conoscitivo”, perchè la teoria neurocognitiva che non può essere fissa e statica, perchè le neuroscienze ogni giorno offrono nuovi contributi; la modellano e la perfezionano. Nel corso degli anni infatti le scienze di base offrivano sempre più contributi che permettevano al riabilitatore di studiare il movimento non solo considerando la contrazione dei muscoli, ma in funzione del ruolo conoscitivo ovvero la necessità dell’uomo di muoversi per sentire e conoscere l’ambiente di cui è parte.
Metodo Perfetti è stato il nome che tutto il pubblico ha affidato a questo approccio, perchè era più semplice difinirlo come metodo, ma il Professore stesso ha sempre guardato con diffidenza questo termine perchè non adatto ad un approccio riabilitativo che si discostava dalle caratteristiche di una tecnica o di un metodo fatto di schemi, sistemi, livelli, pratiche e manovre prestabilite. In seguito dall’Esercizio Terapeutico si è passati al termine Riabilitazione Neurocognitiva dove si evince l’interesse per il corpo, la parte biologica, “neuro” e quella “cognitiva”. Ancora una volta a questo termine spontaneamente viene associato – secondo Perfetti – per distinguerla dalla riabilitazione neurocognitiva in ambito psicologico e per offrire il giusto tributo al suo ideatore, infine un’ultima proposta è stata quella di denominarla “Confronto tra azioni” essendo un termine in grado di spiegare gli ultimi contributi del professore riguardo la struttura dell’esercizio che doveva necessariamente considerare non solo l’azione dell’esercizio, ma anche quella da recuperare e l’azione precedente all’ictus: operando un continuo confronto tra tali azioni. Personalmente da una parte sento la necessità di rispettare il rigore con il quale il Prof. Perfetti è sempre stato attento alla forma e alla denominazione, dall’altra sento la necessità di permettere al pubblico di comprendere questa branca della scienza così complessa, così mi permetto a volte di semplificare alcuni termini, preferibilmente scelgo di utilizzare più spesso e in più sedi il termine Riabilitazione cognitiva secondo Perfetti, ma a volte come in questo articolo introduttivo, sono costretto a lasciarmi sfuggire più di qualche volta il termine “Metodo Perfetti” solo per aiutare il lettore a inquadrare il tema correttamente.
Dove poter effettuare la neurocognitiva di Perfetti?
La neurocognitiva è una attività di riabilitazione che il paziente post ictus potrebbe ricevere fin dai primi giorni di ricovero in ospedale, questo dipende dalla formazione dei medici e dei fisioterapisti presenti del centro di cura. Pazienti e familiari potrebbero rivolgersi al personale sanitario chiedendo la disponibilità di professionisti con tale formazione. In seguito al primo intervento ospedaliero il paziente viene dimesso e ricoverato presso una clinica di riabilitazione convenzionata o casa di cura a lungo degenza, la decisione su che tipo di servizi il malato avrà diritto verrà presa dai medici che faranno una valutazione di alcuni fattori quali l’età, lo stato fisico, capacità cognitive, obiettivi, lo sviluppo di complicanze successive all’ictus. Specialmente nel centro convenzionato è possibile trovare personale con formazione in ambito di riabilitazione cognitiva secondo Perfetti. Negli ultimi anni ho avuto il piacere di poter partecipare alla formazione di molti colleghi in cliniche di questo tipo, per questo anche in clinica provate a chiedere in direzione se potete essere affidati a un terapista esperto in neurocognitiva. Al termine del percorso terapeutico presso il centro di riabilitazione convenzionato, il paziente che avrà ancora bisogno di recupero fisico e di stimolazione delle funzioni cognitive, deciderà di seguire dei programmi di riabilitazione privatamente sia a domicilio o recandosi in un centro privato, dove potrà richiedere al professionista una comprovata esperienza e formazione in riabilitazione cognitiva di Perfetti. Purtroppo il numero dei terapisti che in ambito ospedaliero o convenzionato da cui è possibile ricevere il Conoscitivo è inferiore rispetto alla domanda, in queste strutture le risorse economiche e di tempo a disposizione spesso guidano le strategie riabilitative e le scelte tecniche verso un programma di riabilitazione rivolto all’ottenimento rapido dell’autonomia e a mio avviso a discapito della qualità del risultato: queste necessità non sempre sono compatibili con un tipo di riabilitazione che richiede un impegno solido da parte del professionista in termini di tempo e di formazione.
Anche in ambito privato non è sempre semplice trovare un professionista formato in neurocognitiva che abbia le capacità di prendere in carico il malato di ictus. Rispetto a qualche anno fa, oggi i social media ci offrono un vantaggio e garantiscono maggior visibilità anche ai singoli professionisti che non hanno un sito internet, quindi invitiamo anche a fare una ricerca in rete e nei social dove è possibile anche ascoltare le esperienze dei pazienti stessi.
Alcune Risorse utili
Gruppo Ictus Emiplegia su Facebook
Qui trovi il gruppo Facebook più grande in Italia dove sono ammessi esclusivamente pazienti e familiari – visita il gruppo –
Pagina professionisti dei Neurocognitive Academy
Condividiamo il nostro impegno per cercare di aiutare a colmare questa difficoltà nel poter ricevere terapie di neurocognitive. Abbiamo dato vita a un’Accademia Neurocognitiva, una scuola di formazione per fisioterapisti affinchè si formino in riabilitazione cognitiva, il corso ha la durata di due anni, ma abbiamo voluto pubblicare già i nomi dei professionisti che si trovano nelle fasi più avanzate del piano di studi, sappiamo che la lista è ancora troppo esigua e che in molti non troveranno un nome per la propria città specifica. Il corso di studi è particolarmente impegnativo e non sono molti i terapisti che in primo luogo si appassionino delle malattie neurologiche e in secondo luogo siano disposti a studiare il post ictus, i deficit cognitivi e la neurocognitiva. – visita la pagina –
Programa di Riabilitazione Resilients
Proprio per affrontare questo problema su larga scala è invece attivo da molti anni il nostro programma di riabilitazione a distanza, questo può permettere al paziente di ricevere immediatamente la riabilitazione neurocognitiva coinvolegendo il proprio fisioterapista di fiducia al quale saremo noi a occuparci della sua formazione e lo affiancheremo durante l’elaborazione del piano terapeutico e l’esecuzione degli esercizi. In mancanza di un fisioterapista di fiducia e in attesa di reperirlo il nostro programma nasce con l’intenzione di coinvolgere anche i familiari nel processo di recupero del paziente. Coinvolgere i familiari è stata da sempre una nostra battaglia, perchè il familiare è a stretto contatto con il paziente e anche se non coinvolto direttamente dal fisioterapista, parteciperà a suo modo nel percorso di recupero, per questo è di fondamentale importanza che il familiare sia preparato e formato a gestire il recupero del proprio caro in modo che possa essere una risorsa utile per il professionista e non un ostacolo come spesso viene giudicato. Per maggiori informazioni sul nostro programma di riabilitazione Resilients – visita questa pagina –
Per chi non è adatto il nostro programma?
- Per il paziente al di sotto dei 15 anni
- Per il paziente in coma
- Per chi non ha un un fisioterapista o un familiare che possa aiutarlo
- Paziente con Alzheimer o demenza
Per chiarire: questi diversi fattori appena citati sono i criteri di esclusione per chi vuole accedere ai nostri servizi di riabilitazione, ma non della riabilitazione neurocognitiva in termini generali.
Se prima di iscriverti al programma vuoi ricevere un consulto On-Line con Valerio Sarmati per valutare la tua situazione puoi prenotarlo da qui – Prenota una visita On-Line –
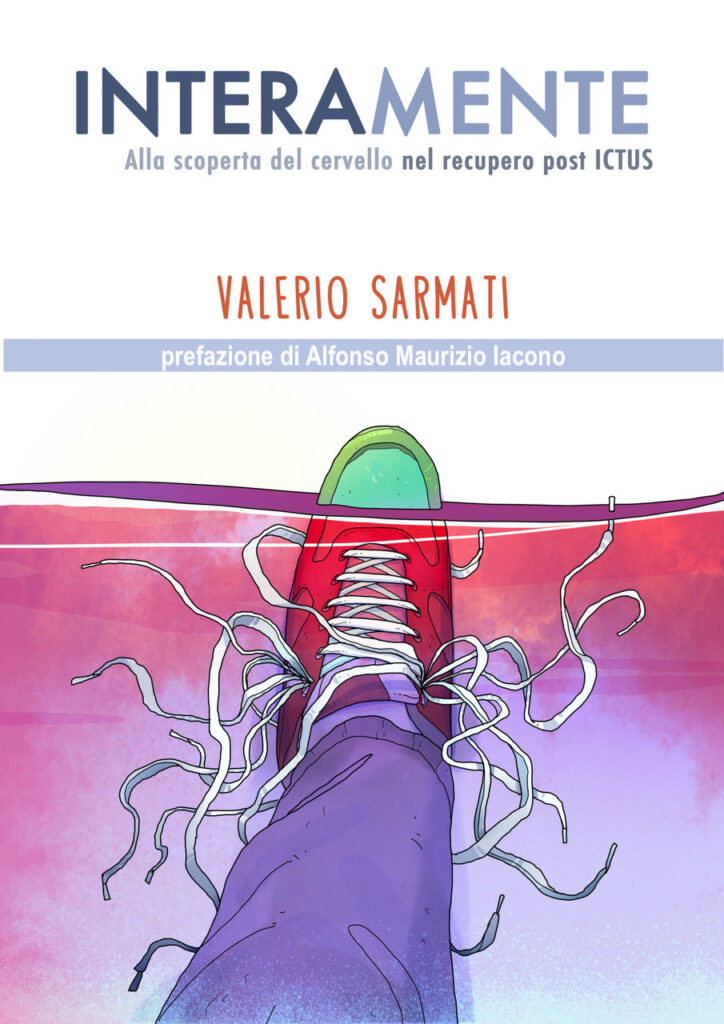
InteraMente
È il libro nato dall’esigenza di condividere con professionisti, pazienti e familiari la mia esperienza con il recupero post ictus e la neurocognitiva di Perfetti, al suo interno ho predisposto 2 capitoli dove potrai trovare molti esercizi con cui iniziare le prime terapie con la neurocognitiva.
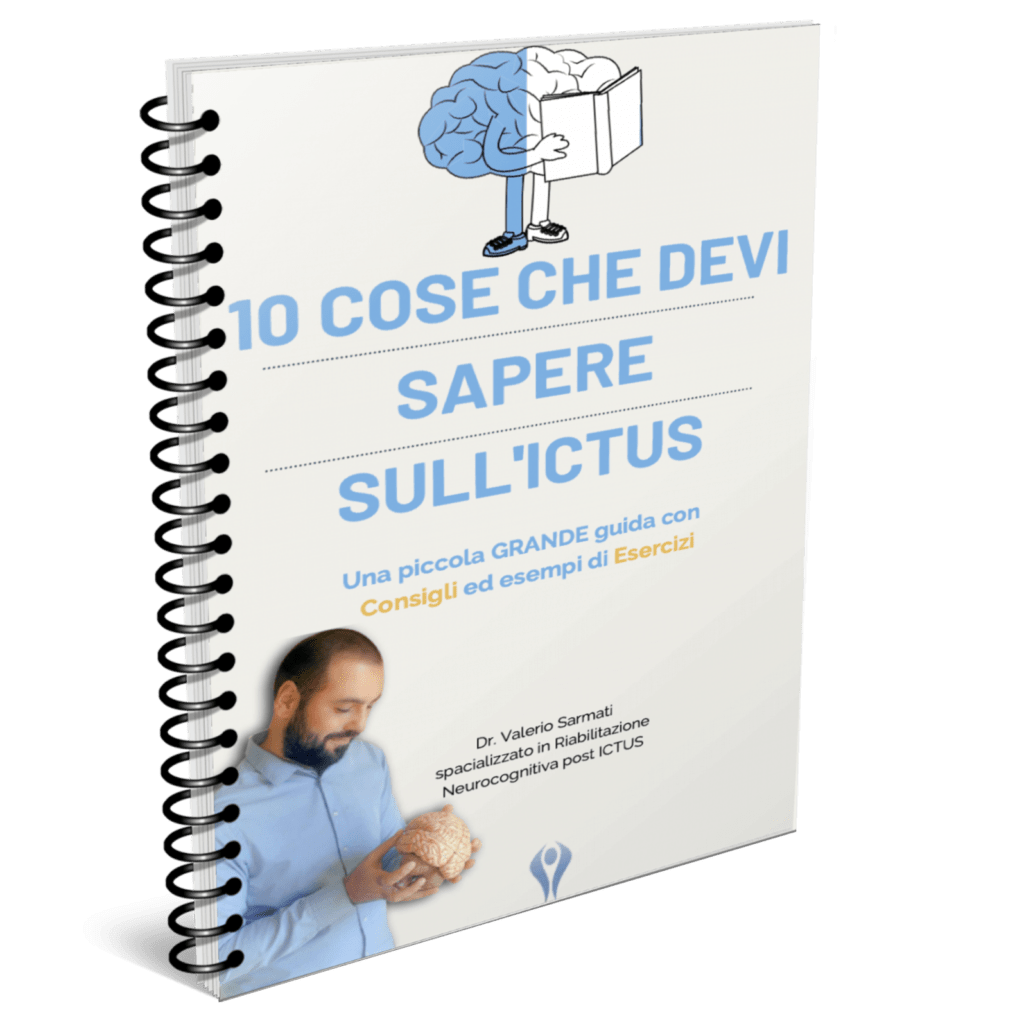
Mini guida
Ho voluto realizzare un piccolo e-book gratuito per dare una panoramica immediata sul problema della riabilitazione dell’ictus. Ci sono 10 cose che devi sapere sull’ictus e in aggiunta ho messo 4 video di esercizi che puoi provare fin da subito in casa con il tuo fisioterapista o con un tuo familiare.
Autore
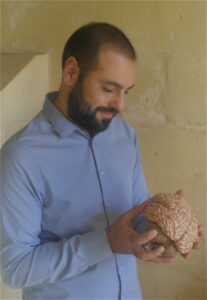
Valerio Sarmati laureato in Fisioterapia e Professioni Sanitarie della Riabilitazione specializzato in Riabilitazione Neurocognitiva del paziente post ictus, docente di riabilitazione neurotraumatologica presso il corso di laurea per fisioterapisti, e di Riabilitazione neurocognitiva al master di neuroriabilitazione dell’università Roma
